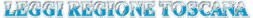
| GIUNTA
REGIONALE
Allegato alla delibera della Giunta Regionale Toscana n°662
del
20/6/2000
DIPARTIMENTO
DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA’
COMMISSIONE
REGIONALE PER LE ATTIVITA’ DIABETOLOGICHE
LINEE ORGANIZZATIVE ATTIVITA’ DIABETOLOGICA e PERCORSO ASSISTENZIALE PER IL
PAZIENTE CON DIABETE |
2. PAZIENTE CON DIABETE IN ETA’ EVOLUTIVA
-
Ruolo del Distretto
-
Azioni:
a) Approccio terapeutico
b) Riconoscimento
precoce delle complicanze
c )Predisposizione
cartella informatizzata
d) Individuazione
standards di autocontrollo
e) Interventi educativi
f) Monitoraggio ed
indicatori di efficacia
4. Ruolo del Distretto.
Vengono erogati nel Distretto i presidi sanitari connessi al trattamento della
patologia. Il Distretto garantisce inoltre il necessario supporto in personale
qualificato ed in mezzi in caso di attivazione dell’Assistenza Domiciliare
Integrata da parte del Pediatra di Famiglia/Medico di Medicina Generale e dalle
Strutture Diabetologiche Pediatriche competenti.
5. Azioni:
a). Approccio terapeutico
L’approccio terapeutico multidisciplinare integrato consente di limitare l’uso
del ricovero ordinario quasi esclusivamente all’esordio clinico della
malattia, mentre nel follow-up deve essere privilegiato il ricovero in regime di
Day-Hospital e la consultazione ambulatoriale.
a.1) Diagnosi clinica di diabete
tipo 1
Il bambino o l’adolescente viene generalmente ricoverato per il riequilibrio
metabolico. Tale ricovero deve avvenire in un reparto pediatrico,
preferibilmente con competenza diabetologica. Il periodo di ricovero dovrà
essere utilizzato per:
-
comunicazione della
diagnosi ai familiari e informazioni sul futuro comportamento alimentare,
sportivo e terapeutico del bambino e dell’adolescente con diabete;
-
riequilibrio terapeutico con
inizio della terapia insulinica;
-
graduale ripresa di una normale attività fisica;
-
inizio di una educazione
alimentare per una corretta alimentazione del bambino e adolescente con diabete
e del nucleo familiare;
-
somministrazione delle prime nozioni di autogestione al paziente e ai
familiari;
-
presa in carico del paziente e del
nucleo familiare sotto il profilo psico-pedagogico;
-
dimissione
con relazione clinica per il Medico curante ed invito ad eventuale incontro con l’Associazione di Volontariato.
Torna a inizio pagina
a.2) Consultazione
ambulatoriale
Nelle prime due settimane che seguono la diagnosi, il nucleo familiare viene
contattato ogni giorno. Per le settimane successive viene proposto il seguente
calendario: 3°-8° settimana, un incontro ogni 15 giorni; 3°-6° mese, un
incontro ogni 30 giorni; dopo il 6° mese, un incontro ogni 1-3 mesi.
In ogni incontro ambulatoriale (la cui durata è genericamente indicata in non
meno di 45 minuti per i bambini prepuberi e di 60 minuti per gli adolescenti)
devono essere valutati, in particolare: altezza e peso, maturazione sessuale,
pressione arteriosa (anche in ortostatismo), cute e siti di iniezione, esame
neurologico; frequenza, gravità e possibili cause di manifestazioni ipo- e
iper- glicemiche; risultato del monitoraggio delle glicemie e della glicosuria a
domicilio; capacità del paziente e dei suoi familiari nell’adattare le dosi
di insulina ai livelli di glicemia; equilibrio psicologico del paziente e dei
familiari; abitudini alimentari.
a.3)
Esami
di laboratorio
Determinazione del fenotipo HLA ed analisi molecolare della regione DQ (in caso
di fratelli), di anticorpi anti EMA (scadenza annuale), anticorpi anti-tiroide
con FT4 e TSH (scadenza annuale), anticorpi anti-parete gastrica (a 5 anni dalla
diagnosi), microalbuminuria (dopo 5 anni di diabete e in pubertà con scadenza
annuale), assetto lipidico compreso HDL e LDL.24 (scadenza annuale),
creatininemia (scadenza annuale), emoglobina glicata (HbA1c) ogni 2-3 mesi,
secondo i casi.
b.)
Riconoscimento
precoce delle complicanze
b.1) - Retinopatia -
Valutazione alla diagnosi di diabete di acuità visiva e del fondo oculare.
Esame del fondo con scadenza annuale. Retinografia dal quinto anno di malattia e
comunque all’esordio della pubertà.
b.2) - Nefropatia -
Determinazione della microalbuminuria (urine della notte) ogni 12 mesi, una
volta compiuti i primi 5 anni di diabete. I valori di microalbuminuria vanno
espressi in mg/min/1,73 mq. Nei pazienti con persistente aumentata escrezione di
albumina deve essere valutata ogni 6 mesi l’escrezione di microalbumina, la
pressione arteriosa e il profilo lipemico.
b.3) - Neuropatia
Dopo 5 anni di diabete, a scadenza triennale, valutazione di velocità di
conduzione motoria (VCM), sensoriale (VCS), soglia vibratoria (biotesiometro) e
tests per la funzione neurovegetativa. Per la complessità e la durata della
loro esecuzione, si auspica che gli esami di laboratorio e strumentali vengano
praticati in regime di day-hospital.
Torna a inizio pagina
c.) Predisposizione
della cartella clinica informatizzata
Deve esistere un registro cartaceo ed un registro informatizzato contenenti
tutti i dati clinici, strumentali e di laboratorio del bambino e dell’adolescente
con diabete. Al fine di facilitare ed uniformare gli interventi, il Gruppo di
studio di Diabetologia della SIEDP ha messo a punto e distribuito a tutti i
Servizi una cartella clinica informatizzata. Tale cartella è raccordabile con
quella degli adulti con diabete ed è stata realizzata in modo da semplificare
il passaggio dell’adolescente con diabete al Servizio di diabetologia dell’età
adulta.
d.) Individuazione Standards di
autocontrollo
Possono essere schematizzati in 3 punti:
d.1)- in periodi di stabilità metabolica e con valori ottimali di HbA1c vengono
consigliati almeno due controlli glicemici capillari al giorno ad orari
differenti e tre glico-chetonurie.
d.2)- in periodi di instabilità metabolica e con valori di HbA1c elevati
vengono consigliati almeno tre controlli glicemici al giorno e tre glicosurie
con chetonuria al giorno.
d.3)- in funzione di questi standard al paziente dovrà essere garantita la
conseguente congrua dotazione dei presidi per l’autocontrollo, compreso l’uso
dei microinfusori secondo le disposizioni regionali attualmente vigenti (
delib.G.R. 965 del 29.7.96)
Torna a inizio pagina
e.) Interventi
educativi
Il tipo di intervento educativo essenziale per l’età pediatrica deve variare
in rapporto all’epoca di malattia e all’età del paziente. Viene individuato
schematicamente un intervento educativo:
e.1) - all’esordio della malattia.
La struttura diabetologica pediatrica con il pediatra/medico di medicina
generale deve spiegare la patogenesi, soffermarsi sulla cronicità della
malattia e deve favorire l’accettazione da parte del paziente e dei suoi
familiari al fine di ottenere la collaborazione necessaria a intraprendere la
strada dell’autogestione della malattia. L’educazione iniziale deve essere
individuale e deve tendere all’acquisizione delle principali conoscenze
teoriche e delle metodiche operative necessarie all’autogestione della
malattia. I tempi necessari per un iniziale insegnamento non devono essere
inferiori a 9 ore di colloquio complessivamente.
e.2) - dopo la prima settimana di malattia.
A distanza di circa una settimana dalla diagnosi di diabete mellito, è utile un
incontro tra genitori ed équipe curante al fine di compilare un profilo
psicopedagogico del paziente e del nucleo familiare. Lo scopo è quello di
acquisire dati sulla dinamica del rapporto medico-paziente e sulle
caratteristiche dell’approccio ai problemi della malattia da parte sia dei
genitori che del paziente.
e.3) - corsi regolari di autogestione della malattia.
Questi corsi si devono articolare su 8-10 incontri della durata di circa 90
minuti ai quali possono partecipare non più di dieci componenti per volta
(separatamente genitori, adolescenti e bambini). Per questi ultimi (8-10 anni)
sono consigliate metodiche di educazione al computer integrate da discussioni di
gruppo.
e.4) - mediante verifica ambulatoriale dell’autogestione.
Il rafforzamento delle informazioni va attuato individualmente ad ogni visita
ambulatoriale (tempo previsto: 45 minuti per il paziente pre-pubere; 60 minuti
per quello in età adolescenziale) con l’intervento, a seconda delle
necessità, del pediatra/medico di medicina generale, del dietista, dello
psicologo, dell’infermiere e dell’educatore.
e.5) - mediante campi-scuola
L’educazione del bambino e dell’adolescente può essere attuata anche in “campi
scuola”, sede di verifica efficace dell’autonomia terapeutica del giovane
con diabete. Il numero ideale di partecipanti a un campo scuola è di 15
pazienti al massimo e la composizione del gruppo deve tenere conto di criteri di
omogeneità rispetto all’età e alla situazione clinica. Adeguato dev’essere
il rapporto numerico fra personale di assistenza e partecipanti al campo: il
rapporto da ritenersi ottimale è quello di 1 accompagnatore ogni 3
partecipanti. Il campo dovrebbe durare non meno di 7 giorni e non più di 10.
Responsabile del campo-scuola deve essere un Pediatra diabetologo. I campi sono organizzati dai Servizi di diabetologia pediatrica
di Firenze, Pisa e Grosseto nella
misura di uno per anno per ciascun Servizio. Nella documentazione clinica di
ogni paziente deve esistere traccia del percorso educativo personalizzato
Torna a inizio pagina
f.) Monitoraggio ed indicatori di
efficacia
Il raggiungimento degli obiettivi di cui alla premessa viene valutato mediante
il monitoraggio dei seguenti indicatori:
1. Controllo glicemico con emoglobina glicata entro i limiti indicati dal
Diabetes Control and Complication Trial (DCCT);
2. Aderenza alle linee guida nutrizionali;
3. Accrescimento in linea con gli standard di normalità;
4. Autonomia terapeutica in funzione dell’età del paziente;
5. Qualità della vita valutata secondo gli standard internazionali;
6. Complicanze :
-a breve termine:
frequenza delle ipoglicemie gravi e/o chetoacidosi espressa come numero di
eventi ogni 100 pazienti/anno;
-a lungo termine: - retinopatia (assente o background), - nefropatia (AER
< 20 mg/m/1.73 mq); - neuropatia (assenza di segni clinici e strumentali di
compromissione neurologica).